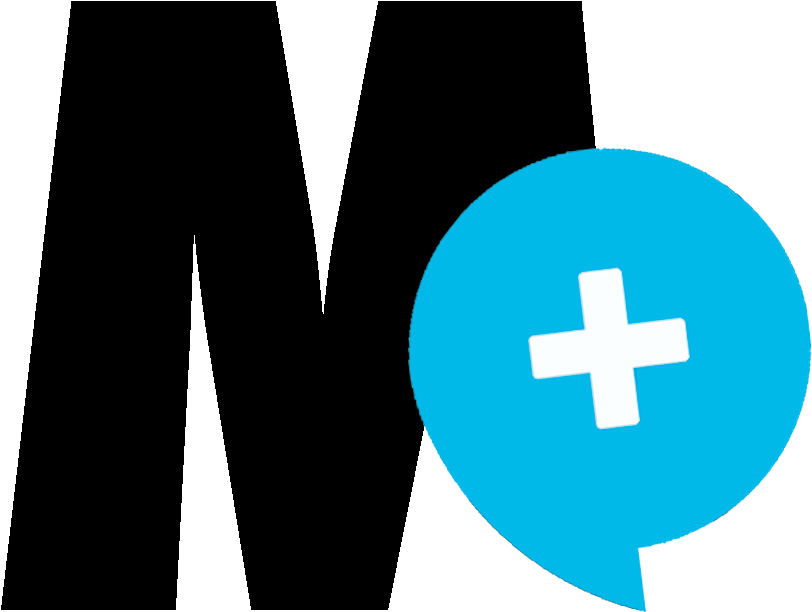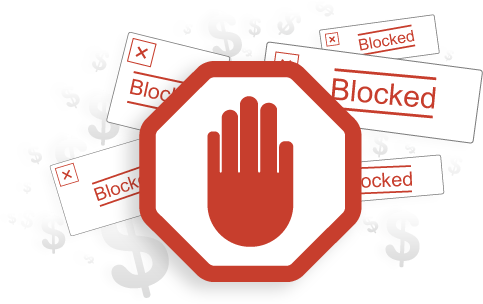Nel paesaggio di Pompei, Piazza Bartolo Longo rappresenta molto più di un semplice spazio pubblico: è lo scenario privilegiato di un dialogo tra funzione spirituale e dimensione urbana. È per quest...
Nel paesaggio di Pompei, Piazza Bartolo Longo rappresenta molto più di un semplice spazio pubblico: è lo scenario privilegiato di un dialogo tra funzione spirituale e dimensione urbana. È per questo che il riavvio del procedimento di tutela indiretta da parte del Parco archeologico di Pompei attorno al Santuario della Beata Maria Vergine ha una portata che va oltre il piano tecnico-amministrativo. Interroga una comunità e le sue esigenze identitarie, funzionali e culturali. Il riferimento normativo è l’articolo 46 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che permette all’amministrazione competente – in questo caso la Soprintendenza – di stabilire una zona di rispetto per salvaguardare l’integrità, la visibilità e il decoro di un bene tutelato. L’intervento si colloca dunque all’interno di una cornice normativa ben definita, che riconosce il valore monumentale del Santuario, già oggetto di vincolo diretto con decreto dell’8 marzo 2022, in virtù del suo interesse “storico, artistico ed etnoantropologico”. Dopo il completamento dei lavori di riqualificazione della piazza, confermato dal Comune di Pompei in data 10 febbraio 2025, il Parco ha effettuato un sopralluogo per verificare la piena restituzione dello spazio alla fruizione pubblica. Da qui il passo successivo: la proposta di suddivisione dell’area in due ambiti – Zona A e Zona B – con prescrizioni differenziate. La Zona A si estende in prossimità immediata del Santuario e ne tutela la frontalità architettonica e liturgica. Qui il divieto è assoluto: nessun manufatto potrà essere installato senza autorizzazione preventiva della Soprintendenza, salvo attività religiose o istituzionali. Lo scopo è duplice: da un lato evitare alterazioni visive e strutturali, dall’altro preservare la percezione monumentale della Basilica e la qualità dell’ambiente sonoro, grazie all’eventuale istituzione di una “zona del silenzio” con emissioni sonore sotto i 40 decibel. La Zona B, più ampia, comprende i tratti di via Roma e via Piave che gravitano intorno alla piazza. Anche qui l’interesse è conservativo, ma con maggiore tolleranza: sono vietati solo gli interventi che alterano lo stato dei luoghi o modificano l’ambiente in modo incompatibile con la destinazione storica e religiosa dell’area. L’operazione si distingue per l’intento dichiarato di costruire un provvedimento “condiviso” con tutti gli stakeholder: cittadini, attività economiche, autorità religiose e amministrative. È urbanistica che si fa dialogo. Oggi sussistono dunque le condizioni materiali e il procedimento può avanzare. Non va dimenticato che la stessa nascita della piazza, negli anni Venti del Novecento, fu pensata come interfaccia funzionale al Santuario: un luogo capace di accogliere il flusso dei pellegrini e di conferire dignità prospettica alla Basilica, anche grazie al contributo economico della Prelatura e all’abbattimento di edifici preesistenti. Una storia che oggi torna a interrogare il presente.