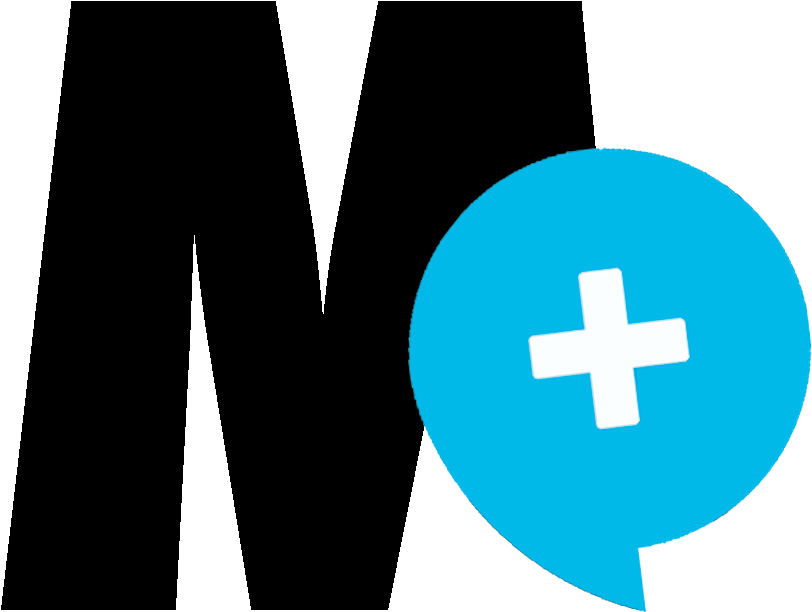È il 24 maggio 1992 e allo stadio Zaccheria si disputa l’ultima giornata di campionato. Il Milan più forte di tutti i tempi ha già conquistato lo scudetto ed è imbattuto. Tuttavia, alla fine del...
È il 24 maggio 1992 e allo stadio Zaccheria si disputa l’ultima giornata di campionato. Il Milan più forte di tutti i tempi ha già conquistato lo scudetto ed è imbattuto. Tuttavia, alla fine del primo tempo, il Foggia, il piccolo diavolo della Serie A, è in vantaggio per 2-1 e rischia di rovinare la festa a Berlusconi, che aveva chiesto ai suoi di concludere la stagione senza sconfitte. Lo stadio foggiano è una bolgia, non è una novità, perchè la matricola di Zeman occupa stabilmente il centro classifica e ha dato filo da torcere a tutti, sia in casa sia fuori. In questo clima da passerella finale, il portiere Franco Mancini si esibisce in un audace “sombrero” ai danni di Gullit e un tentativo di dribbling a Van Basten, che però gli infligge due degli otto gol con cui il Milan punisce la sua irriverenza (finirà 8-2). Per comprendere le motivazioni di questi gesti audaci e avventati, è necessario capire il legame umano e sportivo con il tecnico boemo Zdenek Zeman, iniziato a Foggia nell’87 e concluso drammaticamente a Pescara esattamente 13 anni fa, il 30 marzo 2012, quando Mancini – entrato nello staff del suo mentore – muore ad appena 43 anni a causa di un infarto improvviso. Calcio d’attacco, difesa altissima, lui a sdoppiarsi, portiere e libero, balzo felino e piedi buoni, prerogative che anni dopo sarebbero state richieste a ogni estremo difensore di livello. Mancini fu il precursore, gli altri lo avrebbero poi imitato. Glielo chiedeva Zeman, croce e delizia per i suoi portieri, sempre esposti al rischio. Superato il muro difensivo, toccava a lui, agile e spericolato, neutralizzare le punte rivali, che gli si paravano dinanzi. Mica facile, ma lui sembrava un ragno. Di gol ne prendeva, anche tanti (quasi uno a partita di media, col Foggia) ma li evitava pure, e non pochi. “Higuita italiano” è l’appellativo che tifosi e giornalisti gli affibbiarono per le movenze, i capelli lunghi e lo stile anticonformista già ai tempi in cui giocava in terra battuta al rione “Bottiglione” a Matera. Era un attaccante, fu suo fratello Vito però a intravedere in lui l’anima del portiere, il fiuto e l’intuito tipici di chi impara presto a sventare pericoli. Quando arrivò al traguardo della prima squadra, nel Matera, il preparatore dei portieri Vincenzo Antezza pensava fosse una testa calda, ma dopo appena tre allenamenti tutti capirono di che pasta era fatto quel ragazzino con la vocazione da leader; proprio Antezza dichiarerà, in seguito, di aver rimproverato Franco una sola volta, quando lo beccò ad accendersi una sigaretta sul pulmino della trasferta. Qualche sigaretta se la concedeva lo stesso, soprattutto in sala prove dietro alla sua batteria. Che strano lavoro quello dei batteristi: se sbagliano sono perduti, basta un attimo d’indecisione per rovinare il mood e mandare all’aria un pezzo. O una partita. Perchè batteristi e portieri in fondo sono la stessa cosa, creature solitarie dai quali dipendono miracoli o disastri. Franco Mancini era portiere per professione e batterista per hobby, amava i ritmi giamaicani, il reggae, Bob Marley e da bambino impazziva per Castellini, secondo lui il primo portiere ad interpretare il ruolo con un’alta componente di brivido. Dopo la trafila nelle giovanili, nella stagione ‘85/’86, il Matera lo inserì nella rosa della prima squadra, che si apprestava a disputare il campionato di Serie C2. Iniziò come dodicesimo, alle spalle di Luigino Mattarollo. Ben presto, però, il tecnico Elvio Salvori, lo promosse titolare e lui lo ripagò con 23 presenze e soltanto 17 reti subite. Dopo un altro anno nella squadra della sua città, si trasferì a Foggia come riserva di Stefano Ciucci e poi di Luigi Genovese; il biennio si concluse con la promozione dalla C1 alla B ottenuta da Pino Caramanno, l’allenatore siciliano che lascerà il posto al ritorno di Zeman: due anni prima, infatti, il boemo era stato esonerato da Casillo a causa di un flirt con il Parma, un “tradimento” perdonato per amore del suo calcio visionario e spumeggiante, caratterizzato da pressing, ripartenze e micidiali triangolazioni. Zeman intuì che Mancini, bravo a giocare a pallone, era una sorta di “libero” dietro i difensori centrali, spesso schierati molto alti o costretti a ricorrere alla tattica del fuorigioco. Quando la tattica non funzionava, erano dolori e non c’era altra scelta se non uscire dai pali e sradicare la sfera dai piedi degli avversari, trasformando l’azione da difensiva in offensiva (successe allo Zaccheria contro il solito Van Basten, in un’azione precedente al disastroso dribbling del secondo tempo). Un incubo anche per gli arbitri. Disse Collina: “quando Mancini calciava lungo per Signori, Rambaudi e Baiano, i ribaltamenti di fronte erano troppo veloci anche per me”. Il calcio intanto cambiava di intensità e fisicità e Mancini avrebbe visto tanti «rossi», alla faccia dello spettacolo. Valanghe di gol subiti e salvati ma rendimento eccellente, perchè dietro i grandi del tempo, c’era lui. Dopo Foggia, un mezzo giro d’Italia, passando (tra le altre) per Lazio, Bari e Napoli, dove visse anni difficili e di ricostruzione per la squadra partenopea. L’allenatore degli azzurri era Zeman, il portiere Ferdinando Coppola e dopo alcune indecisioni del titolare, il boemo costrinse la società a intervenire sul mercato, chiedendo espressamente il “suo” Franco Mancini. Da calciatore a tecnico, sempre con Zeman. Prima a Foggia, poi a Pescara dove il destino gli ha tirato lo scherzo peggiore, il gol imparabile.
Rocco Traisci