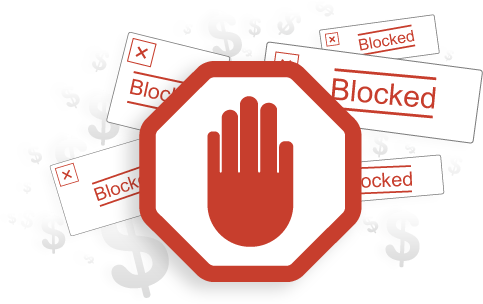Napoli. Una dieta ricca di fibre irrobustisce i batteri intestinali buoni, aumentando la loro capacita’ di difesa contro le infezioni. Anche contro batteri “voltafaccia”, come ad esempio gli Enterobacteriaceae, tra cui Klebsiella pneumoniae, Shigella, E. coli e altri, i quali sono “buoni”, promuovono cioe’ salute se presenti nel microbioma (insieme di tutti i microrganismi intestinali) a bassi livelli, ma che diventano pericolosi in elevate quantita’, ad esempio in presenza di un’infiammazione o dopo avere mangiato cibo contaminato.
In questi contesti questi stessi batteri possono causare malattie e patologie, fino a potere mettere a repentaglio vita quando raggiungono livelli altissimi. E’ quanto definisce un nuovo studio dell’Universita’ di Cambridge, UK, pubblicato oggi su Nature Microbiology. Utilizzando approcci computazionali tra cui l’intelligenza artificiale per analizzare la composizione del microbioma intestinale in campioni di feci di oltre 12.000 persone di 45 paesi differenti, i ricercatori hanno scoperto che la “firma” del microbioma e’ in grado di predire con una certa accuratezza e affidabilita’ se l’intestino sia colonizzato da Enterobacteriaceae oppure no. In particolare i ricercatori hanno identificato 135 specie di microbi intestinali, comunemente presenti in assenza di Enterobacteriaceae, quindi svolgendo un ruolo potenzialmente protettivo contro le infezioni.
Tra i batteri “buoni” sono stati inclusi anche i Faecalibacterium, che producono acidi grassi a catena corta che scompongono efficacemente le fibre negli alimenti. Questo fattore ha spinto i ricercatori a ritenere che un maggior consumo di fibre tramite la dieta, ad esempio consumando verdure, fagioli e cereali integrali possa favorire la crescita di batteri buoni, riducendo quelli cattivi e dunque proteggendo dall’azione di batteri patogeni e anche dal rischio di malattia. Al contrario, assumere probiotici, che non modificano direttamente l’ambiente nell’intestino, sembrano avere meno poter agire sulle probabilita’ di infezione da Enterobacteriaceae.
“I nostri risultati suggeriscono che cio’ che mangiamo e’ in grado di modificare l’ambiente intestinale rendendolo piu’ ostile agli invasori, quindi il cibo e’potenzialmente importante per il controllo della probabilita’ di infezione di una serie di batteri, tra cui E. coli e Klebsiella pneumoniae “, ha dichiarato il dottor Alexandre Almeida, ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Universita’ di Cambridge e autore principale dello studio.
Ad esempio Klebsiella pneumoniae, non solo puo’ causare polmonite, meningite e altre infezioni ma ha sviluppato anche una elevata capacita’ di resistenza agli antibiotici, inducendo gli scienziati a cercare nuovi modi di monitoraggio e controllo, insieme ad altri batteri infettivi simili. Tassi piu’ elevati di resistenza agli antibiotici, riducono le opzioni di trattamento, pertanto l’approccio migliore e’ prevenire le infezioni diminuendo in primo luogo le opportunita’ di questi batteri patogeni di prosperare nell’intestino.
Precedenti ricerche avevano utilizzato modelli di topi per comprendere le interazioni tra i diversi batteri intestinali, tuttavia con dati contrastanti; il nuovo studio sembra invece dimostrare che 172 specie di microbi intestinali possono coesistere con batteri Enterobacteriaceae patogeni, di cui molte specie sono funzionalmente simili ai batteri, avendo tutti bisogno degli stessi nutrienti per sopravvivere. In precedenza si pensava che la competizione per le risorse avrebbe impedito ai batteri patogeni di stabilirsi nell’intestino, con implicazioni anche in termini di trattamento.
Oggi si e’ compreso che assumere probiotici che competono per gli stessi nutrienti con i batteri cattivi per affamarli non sembra una buona strategia, piuttosto sara’ necessario modificare l’ambiente intestinale tramite la dieta, per ridurre il rischio di infezione da Enterobacteriaceae. “Questo studio evidenzia l’importanza di studiare i patogeni non come entita’ isolate, ma nel contesto del loro microbioma intestinale”, ha concluso Qi Yin, ricercatore presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Universita’ di Cambridge e primo autore dello studio.