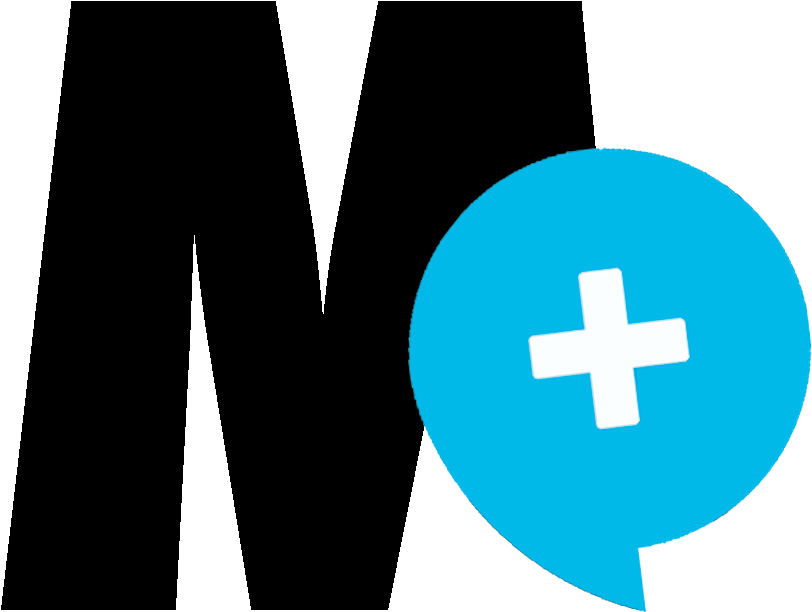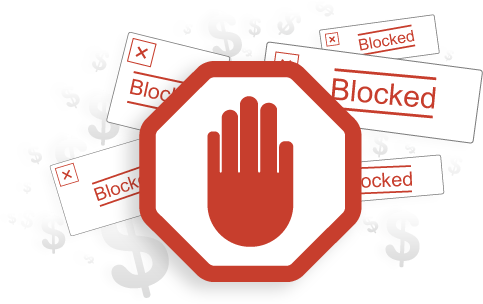Il secolo dei lumi è morto nel Regime del terrore e il sogno di libertà ha scosso i popoli. Il Congresso di Vienna ha appena ridisegnato l’Europa sotto il vessillo della Restaurazione e il motto degli Stati è «conservare progredendo». L’Ottocento si mette alle spalle la rivoluzione francese, e pure Napoleone, tornato dall’esilio per gli ultimi «cento giorni» di potere, è stato spazzato via a Waterloo. Alla fine del Congresso la corona di Napoli scivola via dalla testa di Gioacchino Murat, cognato dell’imperatore e successore del fratello Giuseppe, che paga per il sostegno offerto all’Imperatore rientrato in Francia da Sant’Elena. Sul trono torna Ferdinando IV di Borbone ed è il primo passo per l’unificazione tra il Regno di Napoli e quello di Sicilia. Il sigillo arriva l’8 dicembre 1816, Napoli diventa la capitale e Ferdinando IV diventa re Ferdinando I delle Due Sicilie. La restaurazione del Regno si porterà dietro un peccato originale: quelle distanze mai colmate tra monarchia e tessuto sociale del regno. L’atto che cancella l’autonomia del parlamento siciliano dopo secoli di indipendenza, è adirittura benzina sul fuoco che fin da subito alimenta la campagna antiborbonica che trova consensi tra i ceti più progrediti anche a Napoli. Un terreno fertile dentro il quale la Carboneria affonda le sue radici reclutando adepti nella borghesia, puntando al rinnovamento e alla costituzione divengtando il motore dei moti rivoluzionari. Non a caso, passarono solo 5 anni dall’unificazione del Regno, ed è subito rivolta popolare in Sicilia. Ne trascorsero altri 5 e nel luglio del 1820 il fuoco dei rivoluzionari s’accende anche alle porte di Napoli. Ferdinando è costretto a concedere la Costituzione spagnola ma l’Europa delle grandi potenze lo convoca d’urgente perché i moti napoletani possono essere una minaccia e le idee rivoluzionarie possono essere contagiosi. Ferdinando si defila e con lo scopo di sopprimere il governo costituzionale napoletano che tenta invano la resistenza armata, a marzo 1821 Napoli diventa un regno occupato dalle truppe austriache, con una costituzione sospesa e con una rivoluzione punita con 13 ergastoli e 30 condanne a morte. I 6 anni di regno di Francesco I, iniziati con la morte di suo padre Ferdinando, non risolvono il problema politico della Restaurazione. Lui stesso, favorevole ai moti, governa senza discostarsi dalle direttive austriache. Solo nel 1827 riesce a far sgomberare il regno dalle truppe coccupanti ma pur tenendo carbonari ed ex murattiani fuori dal nuovo Real Esercito, non riesce ad arginare l’avanzata del pensiero politico liberale che continua ad alimen tare il fuoco dell’insurrezione. Solo suo figlio Ferdinando II si dimostra sensibile alle idee liberali e alle esigenze del popolo, e strategicamente richiamanell’esercito gli ufficiali dell’era murattiana. Spinge le riforme nel campo dell’economia e dell’amministrazione dello Stato, diminuisce la fiscalità, favorisce un’oculata spesa pubblica e la diminuzione dei costi di corte. Il suo impulso dà vita allo sviluppo manifatturiero e fa del Regno una culla di primati tecnici, sociali e culturali. Nasce il maggior complesso industriale metalmeccanico d’Italia (Pietrarsa), la maggior industria navalmeccanica (a Napoli e Castellammare). Napoli s’illumina come Londra e Parigi con 350 lampade a gas, spuntano i primi ponti sospesi (il Ponte Real Ferdinando sul Garigliano ed il Ponte Maria Cristina), la prima linea di telegrafo elettrico tra Caserta e Capua, il primo albergo per i poveri (il Real Albergo dei Poveri), la prima ferrovia (Napoli-Portici), la prima galleria ferroviaria (Nocera), il primo teatro lirico (San Carlo), il primo osservatorio astronomico (Capodimonte), il primo osservatorio sismologico (Osservatorio Vesuviano), i primi conservatori musicali, le prime università laiche (Federico II) oltre che diverse scuole di “Arti e mestieri”, il primo sistema pensionistico e il primo statuto socialista del mondo (seterie di San Leucio). Ferdinando II professa l’indipendenza dalle potenze europee e quando il primo ministro britannico manda una flotta militare davanti al Golfo di Napoli, minacciando di bombardare la città, lui mette sul piede di guerra flotta e esercito. Il vento dell’insurrezione nonostante tutto soffia sempre da Sud, dalla Sicilia. E’ l’inizio del 1848, il popolo e la borghesia liberale chiede la Costituzione del 1812, e la rivolta arriva a Napoli. Il re concede la Costituzione, ispirandosi al modello francese: al re spetta il potere esecutivo, mentre quello legislativo lo condivide con il Parlamento che, soprattutto in Sicilia, dimostra subito le crepe tra i democratici e i mazziniani che guardano con interesse all’ipotesi Stato Italiano. Sono proprio i repubblicani ad animare le manifestazioni di Napoli il 15 maggio 1848, il giorno successivo all’apertura della Camera: darricate e piombo, con disordini che costringono il re a sciogliere le camere e indire nuove elezioni. E’ qui che cambia il corso della storia. Ferdinando II è costretto ad agire di forza contro i separatistia e sospende la costituzione. Il sovrano assume una condotta inflessibile che se da un lato gli consente di riprendere il controllo del regno, dall’altro, lo porta ad essere dipinto come un “mostro” dalla stampa liberale europea. Così, anche a Napoli fa breccia l’ideale di Giuseppe Mazzini che predica l’unità d’Italia, un sogno in ragione del quale si organizzano spedizioni di rivoluzionari in vari punti della penisola. Quella nelle Due Sicilie, affidata a Carlo Pisacane, ex ufficiale del Real Esercito, naufraga subito sulle coste del Cilento, ma è una scintilla determinante che rende ancora più debole un regno ormai isolato dalle potenze europee a causa dell’immobilismo deciso da Ferdinando II. Il regno delle Due Sicilie regredisce a velocità doppia rispetto a quella che l’aveva portato all’apice. Inizia persino una fuga di cervelli verso altri regni, soprattutto verso quello dei Savoia, in Piemonte, e giorno per giorno si consolida a Napoli una classe dirigente vecchia e conservatrice. Francesco II, re a soli 23 anni, si ritrova tra le mani un regno in crisi e una nuova ondata di fermento rivoluzionario in Sicilia. Prova ad accantonare la vecchia classe dirigente ferdinandea e s’affidanda a personaggi di fede liberale. Ma ormai la causa italiana monta e dalla Sicilia vengono lanciati numerosi appelli a Giuseppe Garibaldi, che parte con la sua spedizione dei mille e di fatto conquista la Sicilia senza grossa fatica. Il destino è segnato, Garibaldi risale lo stivale e le insurrezioni sono all’ordine del giorno in tutto il regno indebolito ormai militarmente e politicamente al cospetto delle potenze europee. Viene proposto a Francesco II di abbandonare la linea politica austriaca e avvicinarsi alla causa francese, concedendo la Costituzione e occupando lo Stato Pontificio per poi difendere i diritti delle Due Sicilie. Il re accetta in parte il suggerimento ma si rifiuta di attaccare il Vaticano. Decise poi di non combattere a Napoli, ma sul Volturno, e tutto quello che resta dell’esercito si rifugia insieme alla famiglia reale nella frotezza di Gaeta, fino alla resa del 17 febbraio. Le Due Sicilie furono annesse al Regno d’Italia dopo i plebisciti dell’ottobre 1860, in realtà Cavour, preoccupato di una svolta a sinistra nei territori conquistati da Garibaldi, porta all’annessione immediata e incondizionata delle Due Sicilie allo Stato sardo. Il regno cessa di esistere con l’elezione del nuovo parlamento (27 gennaio 1861) e la proclamazione del Regno d’Italia (21 febbraio). A conti fatti la vittoria liberale non porta miglioramenti a Napoli. Oltre alla delusione politica e programmatica, arriva la beffa economica. Persa l’indipendenza i settori produttivi borbonici entrarono in crisi. E finché lo Stato non avvia misure idonee di contrasto, le ripercussioni dell’annessione segnarono la fine delle imprese meridionali piegate dalla concorrenza europea e italiana. Muoiono le Due Sicilie, nasce la questione meridionale.