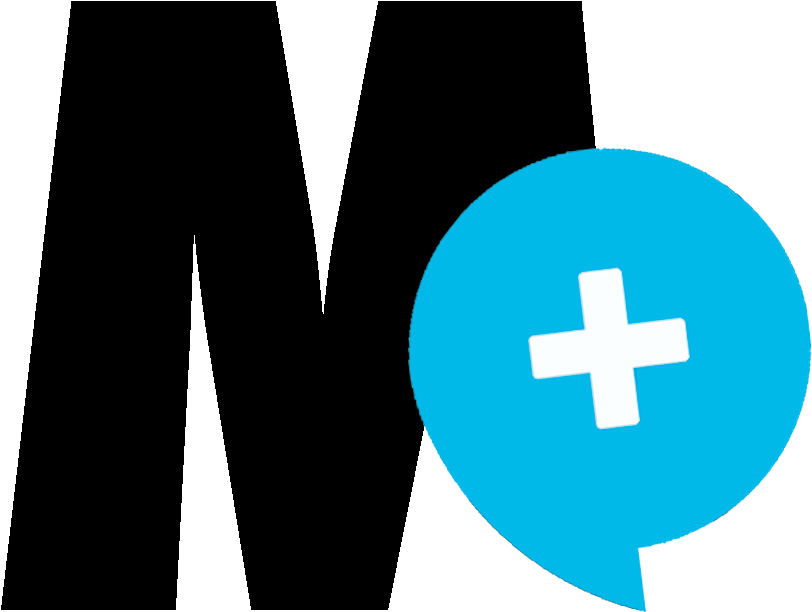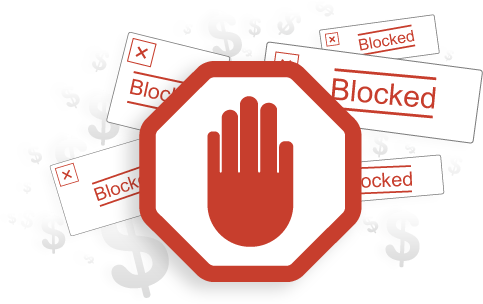All’anagrafe aveva un nome lunghissimo: Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica. Tra i cineasti più influenti della storia del cinema, attore di teatro e documentarista, uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all’italiana. Diceva spesso che «nu cafone ’e fora» – come lui si definiva – può amare Napoli più di un napoletano e più volte pensò di prendere casa a Posillipo. Ma non lo fece mai. Eppure il suo legame con questa terra è stato forte, fino all’ultimo sospiro. Era il 13 novembre del 1974 quando morì all’età di 74 anni a Parigi, in un letto d’ospedale, dopo un delicato intervento chirurgico a cui fu sottoposto d’urgenza per tentare di curare il cancro di cui soffriva da tempo. Vittorio De Sica era un simbolo d’altri tempi, un monumento del cinema italiano del dopo guerra. Apprezzato ovunque, in tutto il mondo. A partire da quella “sua” Napoli – anche se lui nacque a Sora – che ha portato in vetrina con interpretazioni memorabili in film speciali che conquistarono pure l’Oscar. Non ottenne però la statuetta d’oro in quello che è forse il suo capolavoro da attore, nel quale ha recitato assieme a Sophia Loren e che rappresenta una delle tante gemme sparse in una carriera incredibile. Ovvero: «Pane, amore e…». La pellicola di Dino Risi in cui interpretava il comandante della polizia municipale di Sorrento. Qui, nel borgo di Marina Grande, il suo lascito morale è vivo più che mai e viene omaggiato ogni estate quando i turisti ammirano dalle scalinate rese famose dalla Loren un panorama mozzafiato, unico. Che portò Vittorio De Sica a fare toccate e fuga a Sorrento prima di riposarsi nella sua dimora estiva di Ischia.